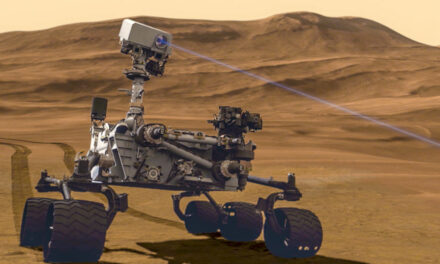Venticinque anni di presenza umana continua nello spazio. È il traguardo segnato il 2 novembre 2025, che ha visto la Stazione spaziale internazionale compiere un quarto di secolo di operatività.
Tutte le persone nate dal 2000 in poi hanno vissuto su un pianeta la cui orbita bassa è stata costantemente abitata da almeno tre astronauti, senza neanche un giorno di pausa. Un’impresa tecnologica e di cooperazione internazionale senza precedenti, iniziata quel 2 novembre 2000 con l’ingresso nella Iss dei membri dell’Expedition 1, missione che sposta a 400 chilometri di quota il domicilio più estremo dell’umanità. Domicilio che in questi venticinque anni vede alternarsi quasi 300 astronauti da diverse nazionalità, che realizzano un totale di oltre 4.000 esperimenti scientifici. Sì, perché la Iss è soprattutto un laboratorio scientifico assolutamente unico: le condizioni di microgravità permettono negli anni di svolgere studi altrimenti impossibili sulla Terra, con applicazioni di frontiera dalla medicina alla biologia, dalla fisica alla chimica. Famosissime tra tutte le immagini degli orti spaziali sulla Iss, che hanno reso possibile lo studio della crescita di piante in ambienti estremi in vista delle future missioni di lunga durata verso la Luna.
Ed è proprio questo futuro, l’esplorazione umana dello spazio profondo, che segnerà l’epilogo dell’incredibile impresa della casa orbitante. Da almeno un decennio ormai si discute del post Iss, con diversi scenari che si sono susseguiti, spesso rispecchiando i diversi equilibri geopolitici. Fino a qualche anno fa la data fatidica del pensionamento della Iss era segnata al 2024, poi spostata al 2028 con l’ipotesi di una gestione mista pubblico-privato. Ma lo scenario che ormai appare certo è quello di una completa dismissione della Iss: non ci sarà un futuro della Stazione Spaziale Internazionale oltre gli anni ’30 del nostro millennio, almeno non come l’abbiamo intesa fino ad oggi.
Frutto della cooperazione tra Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada, e assemblata nello spazio modulo dopo modulo con un importante contributo anche dell’Italia, la Iss è l’esempio più alto di un progetto collaborativo e condiviso tra agenzie spaziali. Un’idea di spazio pubblico al servizio dell’esplorazione spaziale e della scienza.
Quell’idea sta oggi rapidamente lasciando il passo a un futuro commerciale a discapito della visione ‘di compromesso’, ventilata fino a pochi anni fa, che avrebbe visto una presenza pubblica comunque preponderante anche nel post Iss. E invece, il settore spaziale privato prenderà il sopravvento dell’orbita bassa.
La principali agenzie, Nasa in testa, non rinunciano certo all’accesso allo spazio, ma ne cambiano in modo sistemico la gestione: da promotori di un modello di cooperazione internazionale finanziato con fondi pubblici, a principali clienti e utilizzatori di una serie di servizi offerti da privati. Ne è un già un esempio la Crew Dragon, che nel 2020 ha segnato l’indipendenza degli Stati Uniti dalla navetta russa Soyuz – unico veicolo per la Iss dopo il pensionamento dello Shuttle del 2011 – e che di fatto ha affidato il monopolio del trasporto umano a SpaceX.
Ecco, il post Iss vedrà uno scenario simile, anche se su più ampia scala. I successori della Stazione spaziale internazionale saranno infatti avamposti i cui progetti sono in gran parte finanziati dalla Nasa, ma che si svilupperanno come stazioni commerciali indipendenti di cui la Nasa e le altre agenzie spaziali saranno clienti. Tra la fine di questo decennio e l’inizio del successivo i principali progetti che dovrebbero vedere la luce sono Starlab, grande habitat gonfiabile gestito da Voyager Space; Orbital Reef, con capofila Blue Origin, progettato come avamposto modulare in grado di espandersi nel tempo; e Axiom Station di Axiom Space, con un primo modulo che secondo i piani dovrebbe attraccarsi alla Iss già nel 2026 per poi diventare una stazione autonoma dopo il pensionamento della Stazione spaziale internazionale.
E dunque, quale sarà il futuro della Iss? Dopo il 2030, la casa orbitante concluderà la sua lunga avventura con un tuffo nell’Oceano Pacifico, in quella che sarà la più complessa operazione di rientro controllato della storia dell’esplorazione spaziale. 420 tonnellate di materiale bruceranno in atmosfera, e i loro resti si inabisseranno nel cosiddetto “point Nemo”, la zona del Pacifico più lontana da qualsiasi terra emersa. Un’operazione che ha già sollevato non pochi dubbi da parte della comunità scientifica rispetto ai potenziali rischi ambientali. Anche un recente report dell’Unoosa, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico, pone un accento critico sulla pratica di utilizzare l’oceano come cimitero dei veicoli spaziali. La fine della Iss pone dunque l’attenzione anche su uno dei principali problemi che il settore spazio è chiamato ad affrontare: quello della spazzatura spaziale, sul nostro pianeta così come in orbita. Ma questa è un’altra storia.