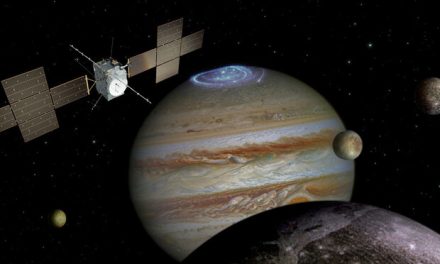Immaginate di osservare porzioni della Via Lattea dall’alto, come se fossimo in un’altra galassia: un punto di vista inedito che non solo affascina, ma aiuta a capire come nascono le stelle e come influenzano l’ambiente che le circonda.
Grazie ai dati raccolti in oltre 10 anni di attività scientifica dal telescopio spaziale Gaia, un gruppo di scienziati ha reso possibile questo scenario, realizzando la più grande e accurata mappa tridimensionale delle regioni di formazione stellare nella nostra galassia.
Rappresentare queste aree non è facile: sono avvolte da dense nubi di gas e polvere che nascondono ciò che accade al loro interno. Gaia non può ‘vederle’ direttamente, ma è in grado di misurare la posizione di milioni di stelle e quanta della loro luminosità viene attenuata dalla polvere. Da qui, è possibile ricostruire la distribuzione della materia interstellare e stimare la quantità di idrogeno ionizzato, individuando quindi i vivai stellari.
La mappa si basa sull’osservazione di milioni di stelle e si estende fino a 4mila anni luce dal Sole. Il risultato è un viaggio 3D attraverso celebri nebulose come Orione, California e la superbolla Orione-Eridano. Non più immagini piatte, ma modelli che permettono di sorvolare e attraversare queste immense nubi, osservando come le stelle più massicce modellano il gas con la loro radiazione ultravioletta, aprendo varchi e creando gigantesche cavità nello spazio. E il meglio deve ancora venire: in futuro, questa mappa coprirà un’area ancora più vasta della Via Lattea, svelando nuove informazioni sul ciclo vitale delle stelle e sull’evoluzione della nostra galassia.
L’Italia ha avuto un ruolo chiave nella missione Gaia, con un contributo pari a circa il 20 per cento dell’intero progetto. In particolare, l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) hanno co-finanziato le attività del Consorzio Scientifico degli scienziati italiani che partecipano al Gaia Dpac (Data Processing and Analysis Consortium); si tratta del consorzio che – costituito da circa 450 tra ricercatori e tecnologi e finanziato in gran parte dalle maggiori agenzie spaziali e istituti di ricerca europei – ha la piena responsabilità della riduzione dei dati della missione.